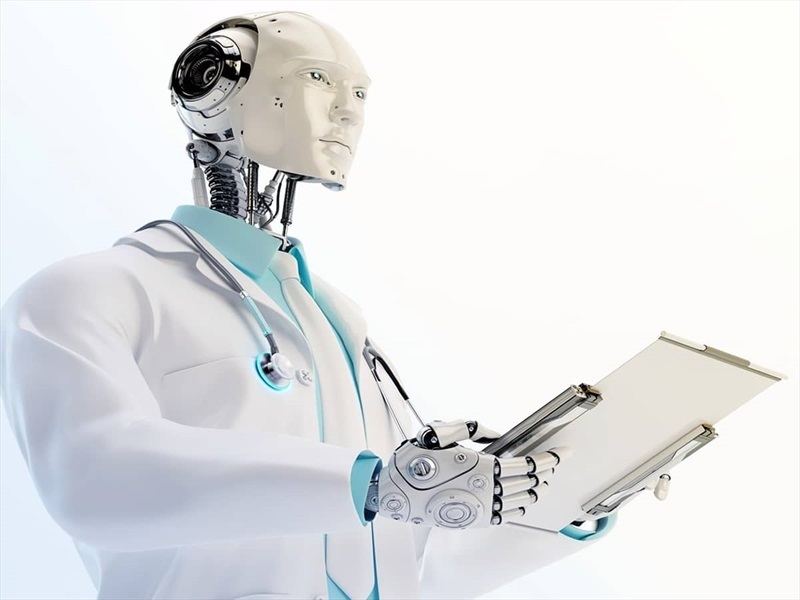Medicina, tecnologia e rapporto tra medico e paziente
Nel 1972 il sergente Norman Penn combatteva in Vietnam e non aveva dubbi sulla sua missione: c’era un nemico da sconfiggere, un territorio da conquistare.
Un giorno, dopo l’ennesimo lancio di ordigni esplosivi, la colonna guidata dal sergente Penn si avviò sulla terra ferma, immaginando di procedere nella perlustrazione di un villaggio appena bombardato in maniera del tutto indisturbata. I soldati vennero assaliti in un’imboscata, sei di loro furono uccisi, gli altri riuscirono a scappare ritornando sull’imbarcazione.
Norman cadde e si ferì alla coscia sinistra procurandosi un taglio profondo che gli impediva di rialzarsi e di camminare. Si vide ormai vicino alla morte, ma dopo qualche minuto di terrore arrivò in suo soccorso un giovane vietnamita che iniziò a medicarlo con quel poco che aveva a disposizione. Il sergente capì che si trattava di un medico, forse un chirurgo, dalla destrezza delicata con cui muoveva le mani, dato che la comunicazione tra i due era praticamente impossibile.
Un essere umano ferito che ha bisogno di cure mediche non è un amico né un nemico, è solo un ammalato e come tale va considerato da qualunque medico. Era probabilmente la logica essenziale di quel dottore vietnamita che gli salvò la vita.
Dopo circa venti giorni le condizioni della gamba erano migliorate e Norman poté essere recuperato dall’esercito americano e rimpatriato.
Dopo circa vent’anni dal Vietnam Norman Penn arrivò al centro trapianti dei veterani, dove lavoravo, per essere sottoposto al trapianto del fegato a causa della cirrosi epatica. Mi raccontava delle sue esperienze del passato, della guerra, dei problemi avuti una volta ritornato negli Stati Uniti, ma avevo sempre la sensazione che non mi tenesse in grande considerazione.
Una mattina uggiosa, tipica di Pittsburgh, mi raccontò la storia della ferita e del medico vietnamita e compresi che ai suoi occhi io, con tutta la mia conoscenza, la mia esperienza, la mia tecnologia, non potevo nemmeno minimamente avvicinarmi alla grandezza dello spirito di quel dottore orientale. Forse lo aveva semplicemente lavato e medicato ma gli aveva salvato la vita, nonostante avesse pochissimi strumenti a disposizione e gli americani fossero i nemici che distruggevano la sua terra.
Mentre Norman era ancora ricoverato ripeteva che una volta ritrovate le forze sarebbe partito per il Vietnam, forse ci sarebbe rimasto per sempre. Diceva che voleva ritrovare quel medico, il suo eroe; probabilmente era alla ricerca di qualche cosa che nella società americana non riusciva a trovare.
Il giorno in cui venne dimesso dall’ospedale, lo accompagnai dalla sua stanza all’uscita e, salutandomi, per la prima volta si commosse come non era accaduto nemmeno quando gli avevamo detto che era salvo e che il nuovo fegato trapiantato funzionava a dovere: «Non sarà la scienza a salvarci – mi disse – e non sarà la malattia a distruggere l’uomo, saranno l’umanità e la solidarietà a condurre alla salute dell’anima».
Penso spesso a questa storia e nel rapporto con i miei pazienti, anche a distanza di anni, cerco di essere come quel medico vietnamita che salvò la vita a Norman Penn, mettendo al primo posto la persona e la cura.
Fare il medico è certamente impegnativo dal punto di vista professionale ma essere medico è ciò che fa la differenza nel modo di concepire e di condurre la propria vita.
Oggi, nell’era della tecnologia, il medico tende a essere individuato soprattutto come un tecnico, conoscitore di soluzioni terapeutiche per ogni tipo di malattia, auspicabilmente infallibile. I medici stessi spesso sono guidati da un certo senso di onnipotenza, dato dalla sensazione di avere il pieno controllo degli strumenti di intervento e diagnosi, il che però li rende freddi e spesso ciechi.
La tecnologia di cui disponiamo oggi ha portato alla scoperta di terapie straordinarie, ma ha anche contribuito a stravolgere il rapporto umano tra medico e paziente. Nella medicina, così com’è intesa nella cultura occidentale di adesso, questo aspetto si sta perdendo, e la professione del medico attraversa un vero e proprio momento di crisi.
Mi sono formato seguendo il principio che tra il medico e l’ammalato si debba stabilire una vera alleanza. Il medico non può curare da solo, come non possono farlo i farmaci, solo la collaborazione con il paziente e la capacità del suo organismo di reagire portano alla guarigione.
Certo, oggi è difficile contrastare l’evidenza che una diagnosi basata su una Tac o una risonanza magnetica abbia più probabilità di essere esatta rispetto a un lungo e approfondito esame obiettivo del paziente eseguito con le mani e lo stetoscopio, tuttavia non è possibile accettare che la tecnologia elimini quel rapporto intimo e particolarissimo che va considerato come parte integrante della terapia.
Il tempo guadagnato grazie alla tecnologia potrebbe essere impiegato nel dialogare con il paziente e creare quel rapporto di fiducia necessario per la cura. Spesso l’elemento diagnostico più importante emerge proprio dal racconto che il paziente fa del proprio malessere e del suo modo di viverlo. Dove non arriva la tecnologia può arrivare l’intuito e il sentire l’altro, nel senso più umano del termine.
La mente umana non è solo una “macchina perfetta”. Nell’unità di mente e corpo, l’uomo ha il privilegio di avere ciò che nessuna tecnologia è riuscita ancora a replicare e mai forse sarà in grado di farlo: la fantasia (capacità di immaginare) e l’affettività (capacità di amare).
Ripongo tutta la mia fiducia nei medici del futuro; sono convinto che, come in una sorta di moto inverso, una reazione al dominio della tecnologia, sceglieranno la strada dell’umanità.
Le Università oggi hanno il dovere di progettare dei percorsi formativi che comprendano anche questo e diano agli studenti motivati la possibilità di essere medici per davvero.
 06.60301809
06.60301809